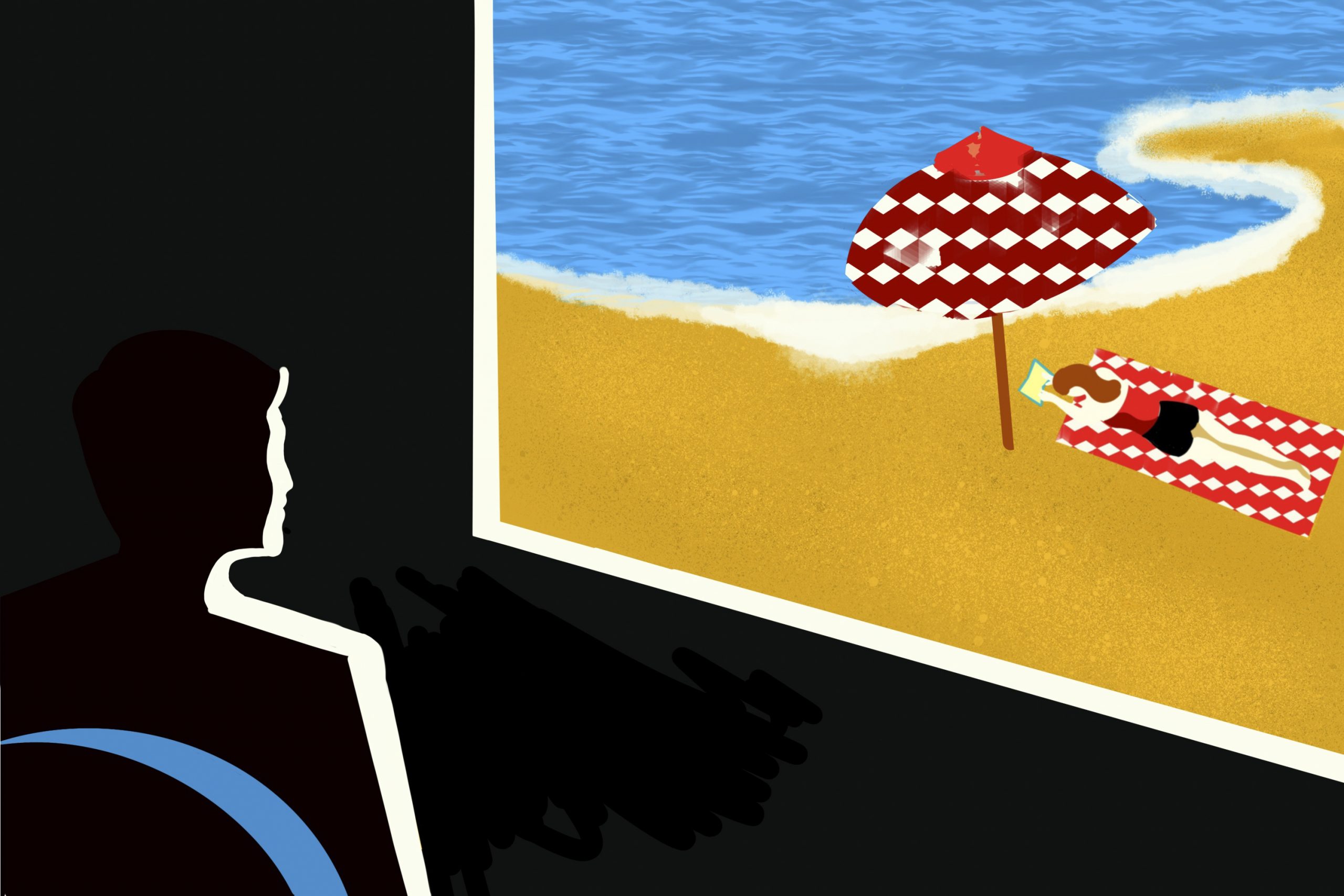
illustrazione di Matteo Sarlo
parole di Luciano De Fiore
Chi non sa spiegarsi qualcosa, spesso evoca il cosiddetto “effetto farfalla”: un battito d’ali a Pechino porta la pioggia a New York. Come a dire: la natura è imprevedibile, niente si ripete e tutto influenza tutto. Oggi, per esempio, senza alterarne il senso: un virus si replica per la prima volta a Wuhan, e un mese dopo fa 30mila morti a New York.
La versione originale è di Edward N. Lorenz, un meteorologo del MIT di Boston in un articolo seminale del 1963, dal titolo Deterministic Nonperiodic Flow nel quale tratta del comportamento caotico in un sistema semplice e deterministico, articolo replicato poi nel libro L’essenza del caos, con il titolo – molto più acchiappante – di Prevedibilità: dal battito d’ali di una farfalla in Brasile può nascere un tornado in Texas?
In effetti, la nebbia dell’incertezza copre il nostro orizzonte attuale e non ci lascia prevedere neppure se riusciremo a fare un bagno a mare il mese prossimo. Il dubbio e il gioco del caso si prestano molto ad essere messi in scena. Basti pensare ai tanti film sul peso che la casualità assume nella vita, da La vita è meravigliosa di Frank Capra, a Terminator di James Cameron, da Destino cieco di Krzysztof Kieślowski al suo remake Sliding Doors, di Peter Howitt. In questi due ultimi, la sorte dei protagonisti cambia nel momento in cui il protagonista prende o perde un treno. Nel film polacco, si susseguono in maniera lineare tre ipotetiche vite del protagonista Witek, tutte generate da un fortuito incidente in stazione. Nel secondo, Helen – la non ancora insopportabile Gwyneth Paltrow – mentre va via dal posto di lavoro perde un orecchino e James glielo raccoglie. In quel momento la sua vita si divide in due dimensioni parallele e in due spezzoni del film: nel primo, prende la metro, nel secondo la perde. Nel primo perderà però la vita, nel secondo la ritroverà.
Un altro film in cui la casualità viene rappresentata al meglio è Match Point, di Woody Allen. La vita del protagonista per due volte dipende dal caso: la prima volta, giocando a tennis, è decisivo un net, un nastro colpito dalla pallina che cade dalla parte che gli è favorevole. Nel secondo, mentre si libera di una refurtiva gettandola nel Tamigi, la fede d’oro della sua vittima rimbalza su una balaustra, ricadendo per strada. Il caso sembrerebbe volgergli le spalle, ma uno spacciatore raccoglie l’anello. Morto poco dopo, verrà ritrovato dalla polizia con l’anello in tasca, e quindi accusato di un delitto non commesso, mentre il vero reo se la caverà.
Prendiamo La La Land. Mia e Sebastian sono impegnatissimi a inverare i propri diversi sogni. E ci riescono, anche a costo di rinunciare l’uno all’altra. Si dovrà pure scavalcare qualche ostacolo lungo la via della gloria no? “City of stars, are you shining just for me?”, si chiede Seb con quella che ha tutta l’aria di una domanda retorica. Le cose avrebbero potuto anche prendere una piega diversa, ma il successo sarebbe stato comunque garantito. Stavolta però l’effetto sliding doors non c’entra: la sceneggiatura rende evidente quanto le scelte siano dei protagonisti. Non si sono persi per un inciampo, per un ritardo, per un trucco. Le farfalle non c’entrano stavolta. Nemmeno loro riuscirebbero a offuscare l’american dream in quella parte specialissima di L.A. che è Tinseltown, lo scintillante quartiere dello spettacolo.
Tutti sanno che Los Angeles si trova a cavallo della faglia di sant’Andrea, nota per i devastanti terremoti che si verificano da millenni nelle sue immediate vicinanze. L’ultimo azzerò San Francisco nel 1906. L’area, tra le regioni geologicamente più instabili al mondo, è anche super monitorata. Numerosi studi prefigurano quello che accadrebbe in caso di Big One, eventualità che è data al 65% entro il 2035. Ma nonostante i piani di evacuazione, la ingegneria civile all’avanguardia e l’attenzione costante della scienza, domina la rimozione che prima o poi la città verrà colpita, anche perché proprio nella zona sud della faglia si sta accumulando da più tempo una gigantesca quantità di energia inespressa.
Ma se anche in profondità qualcosa si muovesse, tutto intanto accade in superficie e sulle creste e le colline che contornano la città. La più famosa è certamente Beverly Hills, alle cui pendici si distende appunto Hollywood. Ad un’istantanea del quartiere della metropoli californiana alla fine degli anni Sessanta è dedicato il film di Quentin Tarantino uscito lo scorso anno, grazie al quale Brad Pitt ha vinto l’Oscar, C’era una volta Hollywood. Mentre una miniserie televisiva, prodotta quest’anno da Ryan Murphy e Ian Brennan, dal titolo simile, Hollywood, la rappresenta com’era nel 1947.
Come nel film di Chazelle, protagonista è un gruppo di aspiranti attori e cineasti calati su L.A. per realizzare i loro sogni a qualunque costo. Siamo a ridosso della guerra, agli albori dell’Età dell’Oro del cinema, dominati dal Motion Picture Production Code, un pesante cancello che sbarrava l’entrata agli studios ad ogni liberalismo, specie sotto forma di “devianza”, vuoi sessuale o razziale. Un codice in vigore dal 1934 fino al 1968 precludeva i teatri di posa a omosessuali e alle persone di colore; del matrimonio non si poteva parlar male, alla prostituzione e alle droghe si poteva accennare solo per condannarle. E così via. Nella serie adesso su Netflix, tutto al contrario, tutti sono disposti a dare tutto di sé stessi, e soprattutto il peggio di sé, in una sorta di controrappresentazione del Codice Hays, come anche venne chiamato, sballandosi e vendendo il proprio corpo e le proprie prestazioni sessuali pur di riuscire. La serie vive di uno strabismo conturbante tra i comportamenti individuali e le capacità professionali dei protagonisti. Così, condensa in sette brevi puntate una sfilza incredibile di ottativi dello star system, rilevatisi occasioni mancate nella realtà dei fatti. E suona quindi come un atto di accusa, per un verso, per quel che a suo tempo si sarebbe potuto forse almeno tentare di fare, e per un altro illumina retrospettivamente uno squarcio rilevante del capitalismo del Dopoguerra che si accingeva ad esportare, anche grazie ai film hollywoodiani, il sogno americano in buona parte del mondo, Italia in testa. Un sogno consumista, pieno di macchine bellissime e potenti, ville con piscina e bellone ossigenate, anteprima, allora a fuoco, del modello da drive in messo in spolvero dalle TV commerciali berlusconiane degli anni Ottanta. Inverando due intuizioni fondamentali della postmodernità. Innanzitutto, che quel che tiene banco, insieme e accanto all’economia reale delle merci, è il metadiscorso che il sistema continuativamente intrattiene su sé stesso sotto forma di spettacolo. E in secondo luogo, che questo discorso si rivolge soprattutto al corpo. Dato che – come scriveva Baudrillard – nella panoplia del consumo vi è un oggetto più bello, più prezioso, più splendente di tutti – ancora più ricco di connotazioni dell’automobile – che tuttavia li riassume tutti: il corpo.
Hollywood ostenta queste verità, attraverso l’assunzione quasi pacifica del corpo come “un bene”, tramutando il bene in merce. Il che vale per la maggioranza dei protagonisti, ai quali il talento arride in misura diversa. E come tale è da piazzare, mettendo avanti le proprie membra. Non importa se si deve promuovere una marca di birra o di pneumatici, il target resta sempre il cliente e il compratore va colpito al di sotto della cintura, facendo leva sui suoi istinti più bassi. Niente di meglio che il corpo e le sue parti-feticcio. Perché, ovviamente, il corpo è un insieme di parti, un insieme di oggetti. L’occhio pornografico hollywoodiano lo scinde nelle sue componenti, strumenti per il piacere dell’altro: il corpo in quanto aggeggio o giocattolo erotico che poco ha a che fare col desiderio che – com’è noto – non ha oggetto.
La serie inizia con un protagonista maschile, Jack Castello (David Corenswet), da poco reduce dalla battaglia di Anzio. Come mille altri bei ragazzi del periodo, sogna di diventare attore, portando con sé la moglie che dopo poco resta incinta. Inizialmente i suoi tentativi di strappare anche una comparsata sono frustrati e la coppia sopravvive grazie allo stipendio da cameriera di lei. La situazione cambia quando Ernie (Dylan McDermott), un fascinoso signore di mezza età padrone di un avviatissimo distributore di benzina dal nome promettente – The Golden Tip – gli offre un lavoro. Ernie sceglie Jack perché è bello e ben presto si capisce perché: la pompa di benzina non è altro che una copertura per un giro di prostituzione maschile. Il distributore non distribuisce solo carburanti ed è frequentato da mezza Hollywood. Soprattutto da signore danarose e appena attempate, spesso tradite a loro volte da mariti succubi di segretarie e starlette, e desiderose di togliersi ancora qualche sfizio. Signore che disinvoltamente vanno a farsi fare il pieno da quei ragazzi aitanti che si offrono in cambio non solo di fruscianti biglietti verdi, ma di promesse di scritture e di parti nelle produzioni degli studios.
Il sogno di Jack l’attore è il medesimo di Archie (Jeremy Pope), se non fosse però che il ragazzo è afroamericano ed è gay. Se sulle capacità attoriali di Jack è lecito dubitare, pare che Archie invece sia davvero dotato come sceneggiatore, almeno a giudizio di Raymond (Darren Criss), che ha letto la sceneggiatura e aspetta solo di farla diventare un film. Anche il regista in pectore ha più di qualcosa da nascondere: è asiatico per parte di madre, e la sua fidanzata Camille di colore (Laura Harrier), anche lei aspirante attrice, è ormai stanca dei ruoli stereotipati di serva o di schiava ai quali è stata fino ad allora confinata.
Chi sembra tessere le fila del complotto che porta a una vera e propria rivoluzione nella produzione, è Avis Amberg, la moglie trascurata di un vero boss di Hollywood proprietario di studios, interpretata da Patti LuPone, autentica star di Broadway, e che qui offre l’ennesima prestazione convincente. È lei che si invaghisce di Jack e ne diviene amante introducendolo ai guadagni di una Dreamland fatta di soldi, e non di sogni, mentre la moglie del ragazzo non regge e lo lascia per un barista. È sempre lei che accredita le capacità scritturali di Archie, ed è ancora lei che sostiene convintamente le chances attoriali sia di un’attrice cinese, sia dell’afroamericana Camille, alla fine premiata anch’ella come migliore attrice protagonista nella notte degli Oscar. In sostanza, la vera protagonista sembra la neo-produttrice, MILF cornificata di un vecchio produttore e infine divertita fuochista di un’esplosione vera e propria quando, cogliendo l’occasione per gestire per un po’ gli studios del marito infartuato, esce dalla propria condizione parassitaria e vara un film di straordinario successo con una donna nera come protagonista, scritta da un gay di colore e diretto da un regista mezzo-filippino. Una virago buona, finalmente libera di quell’edificante sesamo del contenzioso morale borghese che è il buon senso.
Ma il vero soggetto dell’azione è collettivo, il gruppo che sembrerebbe aver inventato una Hollywood nuova, brillante, alternativa. Perfino Rock Hudson (Jake Picking), nella serie col suo vero nome, può vivere in modo aperto la propria omosessualità convivendo con Archie, mentre l’Academy non si farà scrupolo di premiare nella serata degli Oscar come migliore attrice non protagonista anche una grande attrice cino-americana, Anna May Wong. Tutto bello ed edificante, ma falso. D’altra parte, qui ad Hollywood siamo davvero «nel mondo realmente rovesciato, [dove] il vero è un momento del falso», per ricordare Guy Debord. Vero nella finzione, ma assolutamente distopico nella realtà dei fatti di allora, anche se una prima statuetta, in effetti, andò ad un’attrice nera già nel 1940. Il punto originale è che di solito la distopia è negativa, come nella serie appena ricavata dal romanzo di Philip Roth, Il complotto contro l’America, nel quale s’immaginano gli Stati Uniti all’indomani della vittoria di Charles Lindbergh, eroe della trasvolata sull’Atlantico, fervido antisemita e filonazista, diventato presidente sconfiggendo Franklin D. Roosevelt. Il che, tra parentesi, sarebbe potuto accadere davvero, anticipando di più di mezzo secolo la vittoria di The Donald. Invece, in questa serie tutte le palle vanno in buca, sia pure dopo qualche iniziale difficoltà. Tutto va come avrebbe dovuto andare nella migliore Hollywood possibile. Raymond, il regista, lo sintetizza in una battuta: «I film non ci mostrano solo come va il mondo, ma anche come potrebbe andare».
Forse perché tutto accade sotto il cielo sempre azzurro di Tinseltown, la città dei lustrini, mollemente distesa sulla voragine di sant’Andrea. Hollywood a tratti fa ribrezzo per cinismo e durezza, ma in fondo ha il cuore in mano e per i suoi figli vuole solo il meglio. Il destino è amico dei protagonisti, come in La La Land e come nel film di Tarantino, nel quale la riscrizione della storia aveva assunto caratteri ancora più marcati: la tragedia che uccide Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski e incinta di nove mesi, viene virata in happy ending. Tarantino, il regista splatter di molti film ultraviolenti, al nono film si diverte a indossare i panni del deus-ex-machina cambiando il finale e sottraendo Sharon Tate alla strage, perché almeno una volta, almeno nella finzione, per una volta i cattivi non vincano. A Hollywood sono diventati tutti buoni?
Luciano De Fiore insegna Storia della Filosofia Moderna alla Sapienza, Roma. Si occupa di mare, Hegel, psicoanalisi e passioni.



































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
