illustrazione di Matteo Sarlo
parole di Matteo Sarlo
Robert Redford è stato molti uomini, miliardari e carcerati, politici e campioni dello sport, persino spie e truffatori. Ma tutti, in un modo o nell’altro, distinti da due precise qualità, possedere un’etica e tenere fede ad una propria visione del mondo.
Robert Redford è molti uomini. È Jay Gatsby, la leggenda che trattiene negli occhi la luce verde dall’altra parte del molo di Daisy, e John Gage, il miliardario che ha l’ardire di scommettere sulla possibilità di comprare l’amore. È Roy Hobbs, il campione di Baseball ed è Paul Bratter, il giovane neosposino di Jane Fonda in A piedi nudi nel parco. È Warren Justice, il giornalista di inchiesta che muore sul campo in Qualcosa di personale ed è Denys Finch-Hatton in La mia Africa.
Di certo poi Robert Redford è Hubbel Gardiner, il giovane scrittore destinato ad un enorme successo personale che, pur tentando, non riesce a tenere le fila del proprio rapporto con Katie Morosky, una giovane attivista marxista che si batte per tutto e per la quale tutto è una questione di principio. Ma prima che la loro storia inizi, prima che le loro vite si impilino l’una sull’altra, quando lui era per Katie null’altro che il ragazzo più bello e popolare della scuola, in classe una mattina il loro professore di letteratura legge il migliore racconto scritto da chi, tra gli studenti, nessuno avrebbe immaginato. Un racconto di Hubbel Gardiner. Il titolo è Il vero americano sorride.
E questo è l’inizio:
In un certo senso egli era come la nazione nella quale viveva, aveva avuto tutto troppo facilmente. Ma almeno lui lo sapeva.
Soltanto un paio di frasi. Ma è a questo livello immaginario, in cui un attore finisce per essere anche la collezione delle maschere che ha indossato, che queste poche parole del 1973 diventano la descrizione di un uomo che è riuscito a sintetizzare, forse meglio di ogni altro, la leggerezza della vita e la sua complessità, la coscienza spontanea che sorride e nietzscheanamente dice sì alla vita e insieme la sua hegeliana autocoscienza.
Ma chi è, allora, Robert Redford?
Le nostre anime di notte
Oggi Robert Redford è Louis Walter, l’anziano vedovo di Cedar Street che, dopo anni, torna ad aprire di notte la propria porta di casa ad una donna, Addie Moore. Addie, anche lei senza marito, gli chiede di trascorrere le notti insieme. Si tratta allora di parlare e raccontarsi delle proprie vite. Si tratta di non restare soli nella notte. Si tratta di trovare una maniera per scivolarci dentro.
Presentato fuori concorso alla 74esima edizione del festival del cinema di Venezia, Le nostre anime di notte, resa filmica del romanzo di Kent Haruf – un vero e proprio caso editoriale –, è la storia di una rinnovata ultima possibilità. Le nostre anime di notte è una storia su quel che si cela dietro la schiena del tempo. Le nostre anime di notte è l’ultimo film in cui compaiono, di nuovo insieme, Jane Fonda e Robert Redford.
L’incontro
Perché più di cinquant’anni fa Robert Redford è stato anche Bubber Reeves. Avevano iniziano tutti e due insieme nel 1966, quando non avevano ancora trent’anni ed entrambi non volevano fare gli attori. Avevano iniziato insieme, prima ancora di A piedi nudi nel parco: l’ultimo piano, Redford col fiatone e lei che deve attaccare il telefono prima ancora di aver sistemato la mobilia.
Avevano iniziato insieme sul set di The Chase («La caccia»), in quell’epoca della vita in cui quel che semini è sempre di più di quel che raccogli, in cui le intenzioni sono in numero infinitamente superiore ai fatti e i desideri sono sempre millimetricamente spostati dai propri reali proponimenti. The Chase è la storia di Calder, uno sceriffo texano di una piccola cittadina interpretato da Marlon Brando che, sotto pressione da tutta la comunità, deve trovare Bubber Reeves, un detenuto scappato di prigione. Redford legge il copione e alza la cornetta del telefono per chiamare Meta Rosenberg.
RR: «Faccio il film, ma voglio interpretare Bubber Reeves»
MR: «Ma sei fuori di testa, è la parte più breve. Quel tipo non si vede se non alla fine, o quasi».
RR: «Ma è la parte migliore. Bubber è la chiave del film. E in più è un ragazzo rinnegato dalla società e sarà facile per me, visto che per tutta l’adolescenza mi sono considerato un outsider, un tipo fuori le convenzioni».
Non era la parte centrale e dei 5 mesi di riprese Redford è stato sul set solo 5 settimane. Ma Reeves, nelle parole del regista Arthur Penn, incarnava l’innocenza perduta, la purezza dissolta dopo l’assassinio di John F. Kennedy. Un «golden martyr» interpretato dal perfetto «golden boy».
Jane Fonda è la moglie di Bubber. Un anno in meno di Redford e la sua stessa passione per l’arte, che studia a Parigi. Quella per il cinema invece, e per la recitazione, arriva dopo, quando recita al fianco del padre in The Country Girl. Poi si lascia convincere da Lee Strasberg ad entrare all’Actor Studio. Fonda non conosceva personalmente Redford e più tardi dichiarò di «non aspettarsi di esserne così incantata. A parte l’aspetto, la cosa che mi attirò subito è stato il suo senso dell’umorismo. Ma persino al di là di questo, ho riconosciuto un’eco di me stessa all’interno del suo lato più cupo. Come i personaggi nello script, anche noi abbiamo avuto un’infanzia difficile e anche io ho avuto un rapporto complicato con mio padre come lo ha avuto lui».
Charles Redford
Charles, il padre di Redford, era un ragioniere che ha fatto il lattaio, prima di diventare contabile per la Standard Oil. Un uomo molto ordinato e con un retrogusto di antiche spezie. Tutto inizia con un diverbio sulla musica. Una volta lo zio David gli parla di Count Basie e il piccolo Robert si convince che suonare è la sua strada. Quando poi un ragazzo porta a porta gli offre lezioni di chitarra il padre è tassativo: non se ne farà nulla.
Se però riguardo la musica non concede possibilità, riguardo agli sport è esigente sino all’insopportabile. Redford gioca a Tennis per la scuola e nuota per il Bantam Club. Per il padre, però, non è mai abbastanza.
«Odiavo quando i miei genitori mi venivano a vedere perché mio padre era sempre molto critico […] non ero mai abbastanza per lui».
Un talento, quello per gli sport, che è poi rimasto nel DNA dell’attore di Santa Monica che, nei limiti del possibile, non ha mai usato controfigure per le scene di “azione”. Perché c’è qualcosa di molto particolare nel suo modo di recitare, qualcosa che lo allontana dallo Star System: Redford recita col corpo.
Del resto il legame di un artista col corpo, e con il corpus, il legame profondo s’intende, trascende sempre la mera sensibilità. Persino in arti meno “materiali” del cinema, come la letteratura. È James Joyce a confessare, quando riceve la prima copia stampata dell’Ulisse: «Hoc est corpus meus».
Eppure, ed è qui la differenza di Redford, non si tratta di una questione di apparenza contro la sostanza. No, è che Redford abbatte il muro che divide impegno (politico, intellettuale etc..) e bellezza. Togliendo quest’ultima dal mondo del rotocalco, Redford dimostra che la forma è una sostanza invisibile, che al contrario del semplice “attore/modello” riluce ma si sottrae, dà forma ad un’aura che insiste ma non si impone, e quel che dovrebbe contare, l’essere impegnato, non è un fatto di cultura ma l’unico modo di stare al mondo.
Ma allora il sogno di Redford era chiaro, diventare Modigliani. Diventare un pittore. Era stata la madre, Martha Hart Redford, a insegnargli come fare. E così dopo la sua morte, decide di allontanarsi da Santa Monica e frequentare il college all’Università del Colorado, sfruttando una borsa di studio di baseball. Nel 1956 lascia gli studi, lavora in un campo petrolifero e con i soldi guadagnati inizia a girare il mondo. Grecia, Germania, Francia. Vive persino a Firenze «in una stanza molto, molto piccola».
AADA, la svolta
Redford rientra in America e comincia a bere. È allora che incontra Lola von Wegen. Poi accade quel che accade sempre con chi è stato in qualche modo scelto dalla storia, si inscrive all’AADA, l’American Accademy of Dramatic Arts. In altre parole, si rimette dritto dritto sui binari del proprio destino. Durante il primo anno è a dir poco riluttante. Al tempo l’AADA, con sede sulla 52esima a Manhattan, è la scuola di recitazione più tradizionalista sulla faccia della terra. Non esattamente il luogo ideale per uno fuori dagli schemi. Qui recita nel Gabbiano di Céchov e nell’Antigone. Ma è stato Il Gabbiano la svolta:
«fino a quel momento mi limitavo a seguire la formula dell’Accademy. Con Il Gabbiano, tutto è cambiato».
Ecco, per la prima volta Redford capisce come incanalare il suo anti-conformismo. Per la prima volta capisce come svestire i panni dell’outsider. Per la prima volta capisce che è quella la sua strada, entrare dentro lo specchio. Abbassarsi un poco e passare attraverso quella porticina che separa il mondo dei fatti da quello della figurazione.
Poi sono arrivati i grandi successi. Così Robert Redford è diventato Sundance Kid (Butch Cassidy) e Johnny Hooker (La stangata), Joseph Turner (I tre giorni del Condor) e Bob Woodward (Tutti gli uomini del presidente). Così è diventato Denys Finch-Hatton (La mia Africa) e Warren Justice (Qualcosa di personale). Uomini, ciascuno a loro modo, in grado di sopportare lo stesso destino, disposti persino a morire per inseguire il proprio ideale. Tutti tenendo ben saldo il timone del proprio giudizio, fino alla fine non tradendo l’unica vera legge che conoscessero, una legge più forte della norma o del sentimento, quella del desiderio.
Sì, Robert Redford è stato molti uomini, miliardari e carcerati, politici e campioni dello sport, persino spie e truffatori. Ma tutti, in un modo o nell’altro, distinti da due precise qualità, possedere un’etica e tenere fede ad una propria visione del mondo. Il che vuol dire aver chiaro il piano della vita e della sua autoconsapevolezza. Sorridere sì, ma soltanto per meglio cicatrizzarne le ferite. Perché, per dirla con le parole di Hubbel Gardiner, «la vita è troppo seria per prenderla seriamente».
In altri termini bellezza e impegno: Robert Redford.
Matteo Sarlo ha scritto per diverse riviste filosofiche, di critica cinematografica, viaggi, cronaca e narrativa urbana. Ha pubblicato Passagi sul vuoto (Galaad), un saggio sul concetto di «vuoto» in filosofia. È in pubblicazione Pro und Contra. Anders e Kafka (Asterios).

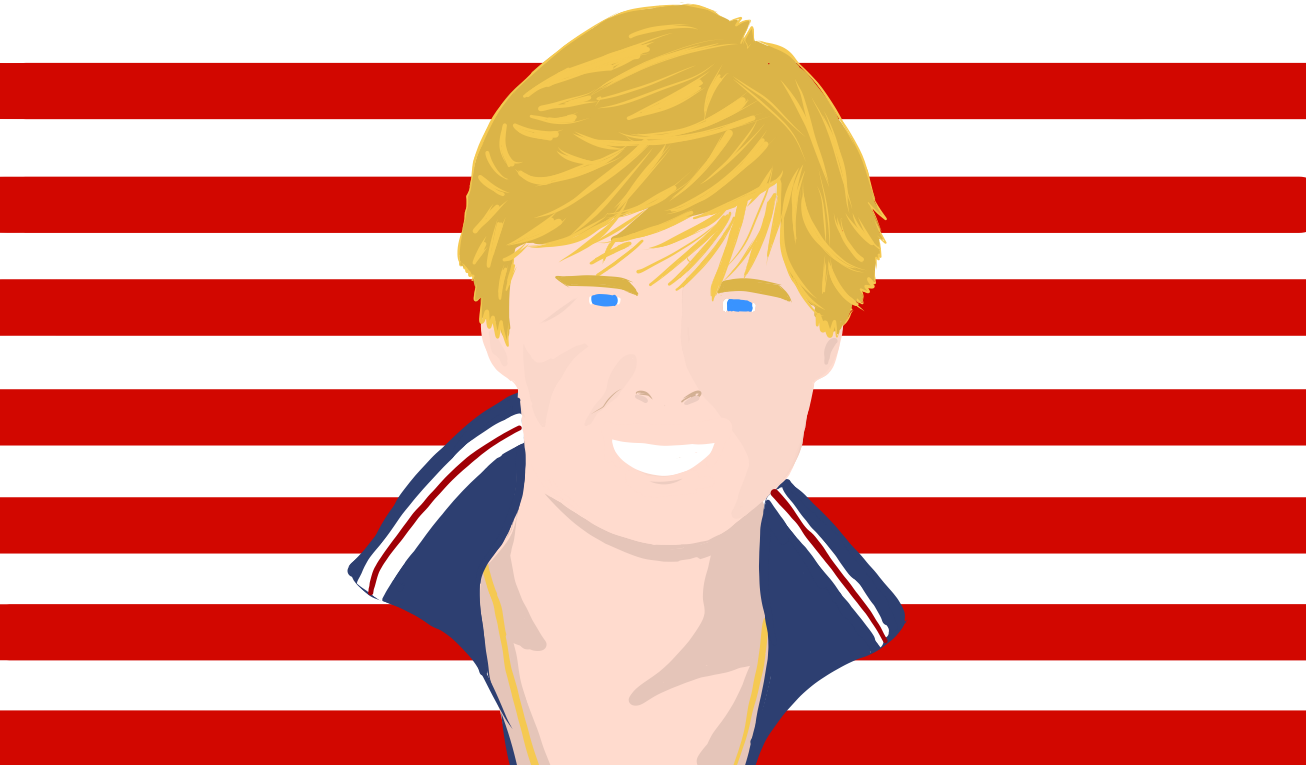



































































![POST-FOTOGRAFIE [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/05/PostFotografie-620x300.jpg)





































![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 2]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM2-620x300.png)




![Black Mirror, o dell’uomo nella Postmodernità [PARTE 1]](https://www.globusmag.it/wp-content/uploads/2018/01/BM-620x300.png)
